
di Letizia Piredda
Non da molto ho seguito un seminario di Andrea Chimento e Simone Spoladori sul montaggio. Inevitabile a un certo punto il discorso sul piano sequenza, il principe delle scelte stilistiche che può fare un regista. Di fronte al piano sequenza spesso c’è una reazione di rigetto: “Ancora quello?” Ma ogni volta che si apre il discorso sul piano sequenza, alla fine ne restiamo sempre affascinati.
Un piano sequenza, invenzione lessicale di André Bazin del 1949, è un’insieme di scene girate senza stacco in un unico e continuo movimento della macchina da presa. In inglese piano sequenza e longtake coincidono. In italiano c’è invece una piccola differenza: possiamo dire che il longtake finisce con il punto e virgola, mentre il piano sequenza finisce con il punto. In altri termini il longtake è un’inquadratura lunga che non esaurisce la sequenza, mentre il piano sequenza a prescindere dalla sua lunghezza mette come abbiamo detto un punto finale.
Ma perché ci affascina così tanto questo elemento stilistico?
E’ vero che da parte dei registi c’è sempre una sorta di fanatismo, un modo di evidenziare con questo virtuosismo la loro bravura, ma in molti casi, tra i più bei piano sequenza che sono stati girati nel corso del tempo ce ne sono alcuni che servono proprio per anticipare quello che sarà il film. Prendiamo a questo proposito il lungo, bellissimo, piano sequenza iniziale de La conversazione, film di Francis Ford Coppola del 1974 (che ispirerà Brian De Palma per il suo Blow Out): è un’introduzione al film, una descrizione funzionale del rapporto di Harry Caul con il mondo circostante, anticipandone la paranoia e la fragilità della percezione sensoriale, mentre alle voci della folla in Union Square a San Francisco, si sovrappongono gli effetti distorti audio, ingannandoci sulla provenienza dei suoni che non coincidono con quello che vediamo. Altre sequenze iniziali possono avere un’impronta noir, come quella de L’infernale Quinlan o pink come quelle di La la land che sottolineano la magia del cinema. Ci sono poi, come sappiamo, interi film girati in piano sequenza. Primo fra tutti Nodo alla gola, 1948 di Alfred Hitchcock: qui sappiamo anche che all’epoca il rullo di pellicola durava circa 10 minuti e che in realtà il film si compone di 11 piani sequenza “cuciti” tra loro, nascondendo i tagli utilizzando vestiti scuri o oggetti.
Per non parlare di Arca Russa (2002) un film di Aleksandr Sokurov. La storia russa raccontata con un’unica sequenza di pianoforte di ben 90 minuti. Un regista contemporaneo si trova magicamente all’interno dell’Hermitage di San Pietroburgo dove farà un viaggio nel tempo di tre secoli in compagnia di un diplomatico russo che appare e scompare. E per sottolineare l’idea del flusso temporale Sokurov realizza (grazie al digitale) un unico piano sequenza in soggettiva.
Non riusciamo ovviamente a parlare di tutti i piani sequenza, neanche di quelli più spettacolari perché sono tanti: dal primo del 1927 del film Aurora di Frederick W. Murnau fino a quello dell’ultima serie televisiva Adolescence (2025) creata da Jack Thorne e Stephen Graham.
Ma quello che è importante sottolineare è che il piano sequenza è un effetto di grande efficacia espressiva, libero da ogni ostacolo tecnico, che dà allo spettatore la sensazione di seguire l’azione nella sua stessa durata. Questa nozione di continuità consente di giocare con variazioni continue di inquadrature, di riprese (dal basso dall’alto, obliqua, a piombo, rovesciata) e di angolazioni visive, di includere frammenti di fuoricampo e di giocare con la profondità di campo.
Insomma con il piano sequenza e con il digitale il cinema può regalare stupori spettacolari inenarrabili, proibiti alle precedenti tecnologie di ripresa.
E noi continuiamo a farci affascinare da queste mirabolanti inquadrature!


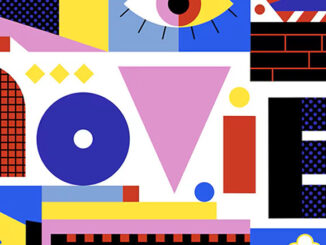


Commenta per primo