
di Letizia Piredda
In una lezione di cinema preparata per il Festival di Cannes, Wong Kar-wai (d’ora in poi WKW) racconta le diverse scelte che fa quando deve fare un film, ma sottolinea, al di là di tutto, un obiettivo imprescindibile: “Quello che conta molto per me è il fatto che la rivelazione dei personaggi e del loro mondo slitti il più tardi possibile e sia la più lenta possibile. Si tratta di costruire la sceneggiatura e la messa in scena come un enigma….Se so senza dubbio che non posso essere Hitchcock, mi piacerebbe filmare come lui. Per me In the mood for love è un thriller , un film di suspense.”[1]
Già da questa breve dichiarazione di intenti possiamo enucleare alcuni elementi indispensabili per inquadrare il regista nell’epoca e nella corrente di cinema di provenienza: anzitutto possiamo dire che WKW è il più occidentale dei registi asiatici, in particolare dei registi di Hong Kong, grazie anche all’incontro con Patrick Tam, suo mentore, che gli farà scoprire il cinema di Rohmer, Antonioni, Jean Luc Godard. Appartiene alla seconda New Wave del cinema di Hong Kong, che produce essenzialmente film di genere (noir, melodramma). Dopo un primo periodo in cui crea video e serie TV , di cui supererà ben presto i limiti intrinseci, WKW elegge il melò come suo genere di riferimento e lo trasforma, superandolo, con la sua forte impronta autoriale. Molto presto il suo cinema si afferma sul piano internazionale vincendo il premio per la miglior regia a Cannes, 1997 con il film Happy Together. In questo film, come già nei precedenti, sono presenti le due tematiche portanti del suo cinema: Il tempo e Hong Kong. Rispetto a quest’ultimo il regista dice: “Esiste in tutti i miei film come un vero e proprio personaggio”[2]. Hong Kong, dove WKW si è trasferito da Shangai prima della rivoluzione culturale, ha un risvolto affettivo centrale nella sua vita: è lì che passa l’infanzia e l’adolescenza, è lì che si forma sul piano culturale, attraverso la passione del cinema e quella per la lettura, trasmessagli rispettivamente dalla madre e dal padre. E lì che vive all’interno della comunità di Shangai che fa fatica ad integrarsi, sia perché molto radicata alle sue origini, sia per la differenza dei dialetti, mandarino a Shangai, cantonese a Hong Kong.
Prima di diventare il film che conosciamo In the mood for love era uno dei tre corti di un progetto Tre storie sul cibo che aveva lo scopo di analizzare come il cibo influisce sulla vita della comunità cinese e come alcune innovazioni, come il bollitore elettrico, le tagliatelle istantanee e il fast food hanno rivoluzionato le relazioni sociali, in particolare quelle tra uomo e donna. Di fatto la storia è diventata sempre più lunga e si è trasformata come un’opera a sè stante, un lungometraggio che ha richiesto ben quindici mesi di lavorazione. E questo spiega come mai il cibo riveste una parte importante nel film.
Ma la fonte d’ispirazione da cui WKW ha tratto il tema centrale del film, quello dell’opacità del ricordo, è un romanzo breve: Un incontro di Liu Yichang.
In the mood for love è la storia di un uomo, Chow (Tony Leung) e di una donna Su (Maggie Cheung) che non riescono a vivere il loro rapporto d’amore, in parte perché restano vittime delle convenzioni sociali, e in parte perché non vogliono cadere in un’altra forma di conformismo, l’adulterio borghese, come invece hanno fatto i loro rispettivi partner.
E’costruito come un thriller, un film di suspence da cui emergono man mano degli indizi. Tali indizi, però, non emergono da una struttura narrativa classica, ma all’opposto da una costruzione narrativa rarefatta, caratterizzata da una totale disarticolazione del tempo e punteggiata da continue ellissi temporali: una narrazione che avviene attraverso il tempo della memoria.
Tutto il film si snoda da un lato con l’attesa di un desiderio (l’unione della coppia) che resta inappagato; ma dall’altro è un’attesa che si svolge al passato e che si riattualizza nel ricordo di lui.
E qui il richiamo a Alain Resnais ( L’anno scorso a Marienbad, 1961) è evidente [3]: tutti e due i film si basano sul fluire della memoria, o meglio sul tentativo continuo e reiterato di superare l’opacità della memoria.

Come viene sottolineato nel cartello finale del film: “Quando ripensa a quegli anni lontani è come se li guardasse attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato e indistinto”.
Per rendere questa difficoltà legata all’opacità della memoria Wong Kar-wai ricorre ad alcune precise scelte di stile: anzitutto ricorre ad una restrizione dello spazio e all’uso dello slit staging [4], letteralmente la messa in scena della fessura, dove la scena è visibile solo in porzione ridotta o ostruita dall’interposizione di elementi (una lampada , una sedia, una tenda semitrasparente); il fuori campo è inesistente, o è reso possibile in un gioco di specchi che aumenta le distanze rispetto alle immagini riflesse, creando un disorientamento percettivo in cui non sappiamo più se l’immagine che vediamo è ripresa direttamente o è riflessa attraverso lo specchio.






E se il tempo è un elemento che sovrasta tutta la storia, come sottolinea l’immagine plastica di un orologio in primo piano e la figura di Su sfocata sullo sfondo, la claustrofobia degli spazi sottolinea la difficoltà del ricordo a emergere a farsi strada, e al fatto che può muoversi solo in meandri nascosti e tortuosi.

Ma ritorniamo un attimo sulla scena che ho appena citato: l’orologio che troneggia nell’inquadratura, occupando quasi tutto lo spazio, e la figura di Su che vediamo sfocata sullo sfondo e posizionata di lato. I significati veicolati da questa scena sono molteplici. Anzitutto la donna è dominata dal tempo in quanto non riesce a fare una scelta, e quindi non è in grado di dominare la propria vita. Questo aspetto verrà rappresentato anche con inquadrature parziali dei corpi. Un altro aspetto riguarda la relazione tra persone e oggetti[5]: anche gli oggetti possono prevaricare, soffocare i corpi, emarginarli o opacizzarne la visione ( i vetri, le vetrine, le tende, il fumo, i vapori).
Gli spazi ristretti che negli anni ‘60 sono una realtà diffusa a Hong Kong, dato il sovraffollamento e la conseguente promiscuità delle coabitazioni, acquista anche altri significati importanti: l’impossibilità per i protagonisti (Su e Chow) di evadere dalla società claustrofobica dell’epoca dove l’etichetta prevale sui sentimenti dei singoli; il futuro stesso di Hong Kong che è altrettanto senza via d’uscita, dato che nel 1997 ci sarà il ricongiungimento con la Cina [6].
Dobbiamo ricordarci che Hong Kong è un non luogo dove Oriente e Occidente si incontrano, ma non sempre si integrano, quasi privo di una storia e di un’identità, un luogo di passaggio, precario come sono precari i sentimenti dei due protagonisti:
la precarietà umana dei sentimenti e quella culturale del cinese di Hong Kong si intersecano in una rete di analogie e parallelismi che spesso restano sotto traccia.
Un altro meccanismo molto utilizzato dal regista è quello della ripetizione: moduli musicali, visivi e narrativi si succedono incessantemente, il percorso dei due protagonisti che vanno e vengono di continuo dal noodle shop, la musica che li accompagna, il ralenti che dilata ancora di più l’azione: ma nessuna ripetizione è uguale all’altra, c’è sempre un elemento che cambia: il vestito (qipao) di Su, la posizione dei protagonisti di fronte o di spalle, l’avvicinamento o la distanza, l’incontro. In altri momenti, come quando Su va a trovare Chow nella stanza d’albergo, l’utilizzo di un montaggio iterativo che riprende il passo della donna e il ripetuto saliscendi lungo le scale, ci rivelano la sua esitazione.




E il motivo musicale Yumeji’s Theme che si ripete insieme al loro andirivieni, e la musica in generale sembra diventare un elemento che non si limita ad accompagnare le azioni dei protagonisti, ma diventa una sorta di linguaggio inscindibile che segna i momenti di più alta partecipazione emotiva da parte dello spettatore e a volte l’unico elemento che collega i due protagonisti quando sono lontani o magari divisi da un muro, ad esempio mentre ascoltano alla radio, appoggiati da un lato e dall’altro della stessa parete, una canzone cinese.

Ma se, come abbiamo visto, lo spazio ristretto elimina il fuori campo, inteso come spazio che va oltre il quadro, il fuori campo viene inserito nella narrazione: infatti non vediamo mai, ma solo di sfuggita all’inizio, i rispettivi consorti dei due protagonisti, che diventano sempre più presenti grazie alla loro assenza. Come aveva anticipato all’inizio, WKW vuole costruire il film come un thriller ed è per questo che mantiene l’uomo e la donna adulteri fuori campo, per creare mistero.




Su e Chow infatti, dopo aver scoperto la relazione tra i due partner, cercano di capire come sono potuti arrivare all’adulterio. Fino ad arrivare alla decisione di recitare loro stessi la parte dei rispettivi coniugi. Un rapporto recitato va a sovrapporsi al rapporto in fieri che hanno paura di vivere sia per le resistenze interne, sia per la difficoltà a lottare contro il conformismo sociale.
Il peso dell’assenza, caratterizza la parte finale del film: dopo che Chow ha lasciato la stanza 2046, un anticipazione del prossimo film, partendo per Singapore, ritroviamo Su in quella stanza piangente, come se, abitando lo spazio più intimo di Chow, potesse trattenerlo.
La scena si sposta in Cambogia, con uno scatto realistico: un cinegiornale che riprende l’arrivo trionfale di De Gaulle a Phnom Penh: improvvisamente con l’affacciarsi della Storia, il pubblico prende il sopravvento sul privato.
Chow si reca alle rovine del tempio di Angkor per seppellire per sempre il suo segreto : quando uno aveva un segreto e non voleva che nessuno lo sapesse, andava in montagna e cercava un albero , scavava un buco nel tronco, vi bisbigliava il proprio segreto e poi richiudeva il buco con il fango, così il segreto non sarebbe mai stato scoperto da nessuno.

Chow segue questo rito scavando un buco in un muro cadente del tempio e poi scompare, mentre la macchina da presa continua a riprendere il tempio, le rovine: un richiamo evidente all’Eclisse di Antonioni, in cui con la sparizione dei personaggi, in questo caso di Chow, lo spettatore è consegnato al vuoto dello spazio non abitato.
Film profondamente empatico, suggestivo, etereo, poetico, in cui forma stilistica e contenuti si integrano perfettamente, con una musica struggente che diventa parola e in cui Oriente e Occidente si intersecano in un connubio inestricabile[7][8].
* * *
Note
[1] AA.VV, Lezioni di cinema. Il Castoro, 2007 p.138
[2] Marco Dalla Gassa, Dario Tomasi. Il cinema dell’Estremo Oriente. Utet,2010,
p.331
[3] Leonardo Gliatta. Wong Kar Wai. Dino Audino Editore, 2004, p.28
[4] Silvio Alovisio. Wong Kar-wai. Il Castoro,2010 p.143
[5] Secondo alcune filosofie buddiste gli oggetti possono diventare persone (v. in
Hong Kong Express i pelouches con cui parla il poliziotto) e le persone in oggetti
(vedi gli androidi di 2046). Inoltre secondo la tradizione filosofica cinese, una
sorta di neoconfucianesimo, l’emozione è sempre legata alla necessità del suo
controllo.
[6] Il riferimento è all’accordo raggiunto nel 1984 tra Gran Bretagna e Cina Popolare,
che prevede il rientro di Hong Kong alla madre patria per il 1/07/1997.
[7] John Powers.WKW: The cinema of Wong Kar-wai, Edizione inglese,2010
Per vedere il libro clicca qui
[8] Questa recensione è stata presentata come Saggio al termine del Corso di Critica Cinematografica
tenuto da Longtake nel Novembre 2021.



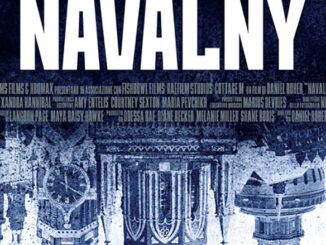

Commenta per primo