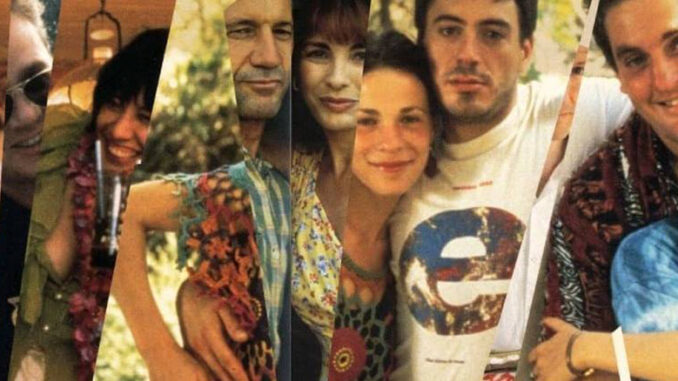
di Gianni Sarro
Robert Altman non è stato un enfant prodige, se pensiamo che coglie la sua prima affermazione come regista cinematografico con MA.S.H. (1971) quando ha già quarantacinque anni. Altman agli inizi degli anni settanta, viene da una lunga gavetta in tv, dove, tra gli altri, ha lavorato anche per Hitchcock, girando alcuni episodi della serie Alfred Hitchcock presenta. Una serie di telefilm, di un’ora ciascuno, dove il maestro della suspense condensa storie adrenalitiche e avvincenti. È in questo contesto che nasce l’idea di Psyco (1960), poi diventato il film per il grande schermo che tutti conosciamo.
Altman con M.A.S.H. afferma, come poi farà durante tutto l’arco della sua produzione, che il cinema non è la realtà, bensì uno specchio. Deformante. Un prisma che rimanda indietro tanti frammenti; non contribuisce a ricreare un insieme, al contrario restituisce tante schegge di realtà.

Pensiamo alla scena degli specchi in La signora di Shangai (1947) di Orson Welles, dove il racconto si frammenta, si scompone. Le immagini si sovrappongono in un tourbillon indecifrabile. I volti dei personaggi diventano uno, nessuno, centomila. Per il cinema della modernità (Welles, ovviamente, ma non dimentichiamo, tanto per fare un solo nome, Renoir) la realtà è irrappresentabile. Perché la realtà non è oggettiva, non è unica bensì molteplice, non imprigionabile in forme immutabili. E così il cinema. La forma cinematografica, il suo linguaggio, il modo di raccontare qualcosa o qualcuno ha molteplici possibilità di essere mostrato.

Apprende e sviluppa questa lezione Altman, che scardina tutti i meccanismi del cinema classico, che suggerisce una realtà lineare e ordinata. Sempre in M.A.S.H la narrazione è composta da un accumulo di frammenti che non contribuisce a formare un quadro unico. Tutto rimane sfilacciato. Non c’è volontà di comporre un racconto compiuto. Come dimostra l’altoparlante del campo. Incespica sulle parole. S’impappina sulle comunicazioni. Crea un cortocircuito tra diegetico e extradiegetico, poiché quell’altoparlante rappresenta l’istanza narrante, che candidamente confessa di non capire e, soprattutto, di non saper spiegare quanto racconta.
In I compari (1971), western con Warren Beatty, assistiamo ad un altro canone del cinema classico destrutturato: il climax del duello finale; nella sparatoria finale, momento sacro per antonomasia del western, il duello è contaminato con un’altra scena, quella dello spegnimento dell’incendio di una chiesa. La sovrapposizione ha l’unico scopo di diluire la tensione emotiva ingenerata nello spettatore dall’esito dello scontro finale. Questa lunga scena è un ben curioso (e ben congegnato) uso del montaggio alternato, ossia due azioni che si svolgono simultaneamente in luoghi diversi. Sin dagli inizi il cinema, ci ha abituato a vedere convergere in un unico punto spazio-temporale le due serie rappresentate. Pensiamo a Nascita di una nazione (1915) di Griffith: la colonna degli eroi riuscirà ad arrivare in tempo a salvare la famiglia assediata in una casa.

Ne I compari invece Altman con le immagini dell’incendio crea un anticlimax, le due azioni non convergeranno in un unico punto e il duello perde tutto il suo impatto emotivo. Si svolge quasi in silenzio. Lontano. Ovattato.
Nel cinema di Altman l’ordine iniziale non è mai ripristinato, come è mostrato in America oggi; è confusione, nel senso di un fondere insieme; è il disorientamento dell’happy end che non lo è come vediamo in I protagonisti. O, ancora, l’immagine iniziale di Pre-a-porter, dove il nostro sguardo è attratto dalla scritta posta sull’etichetta di una boccia di profumo: «poison», ossia veleno. Quale veleno? Quello dell’immagine proposta dai media, falsa e affabulatrice, confusa. D’altronde La Bella confusione era il titolo a cui inizialmente aveva pensato Fellini per Otto e mezzo. Altro film che suggerisce come l’immagine sia rappresentazione e non realtà.
Flavio De Bernardinis. Robert Altman. L’Unità – Il Castoro, 1995
David Thompson (a cura di),Altman racconta Altman. Kowalski ,2007

Commenta per primo